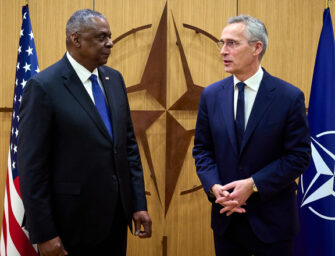L’Italia accoglie il “piccolo Messi ” afghano. Murtaza è in salvo.
di Chiara Sulmoni, Claudio Bertolotti, Andrea Molle
info e contatti: info@startinsight.eu
Murtaza, il ragazzino appassionato di calcio noto come il piccolo Messi afghano, costretto per anni a vivere in fuga e nell’ombra a causa delle minacce dei talebani e di altri gruppi criminali, è finalmente in salvo con la sua famiglia in Italia. Come per altri nuclei famigliari per i quali START InSight si è adoperata per il salvataggio dall’Afghanistan, per lui si cercava una soluzione fin dai giorni caotici dell’evacuazione seguita al cambio di regime a Kabul. La svolta è arrivata dopo 18 mesi di tentativi e di attesa, grazie a Caritas Italia, co-organizzatrice dei corridoi umanitari dal Pakistan aperti lo scorso autunno.

Mentre prendeva avvio tra noi una comunicazione destinata a durare a lungo, in cui concisi “come stai, sei al sicuro?” si sarebbero alternati a lunghi periodi di attesa, a domande senza una risposta certa, a frasi di sconforto e preoccupazione, qualche fotografia e emoji a forma di cuore, nei giorni successivi all’ingresso dei Talebani a Kabul, la popolazione afghana si riversava come un fiume in piena verso l’aeroporto, in cerca di una via d’uscita.
I primi messaggi scambiati su Whatsapp con Mahdia, la sorella maggiore di Murtaza che sarà la nostra interlocutrice per tutto il tempo, risalgono alla terza settimana di agosto del 2021 e raccontano la paura e la precarietà della vita quotidiana: “adesso rimaniamo solo in casa, ma pensare al nostro futuro incerto ci fa stare male psicologicamente. Da un po’ di tempo, credo di poter dire che non ci sentiamo più sicuri neanche all’interno, visto che hanno minacciato Murtaza tante volte prima d’ora”.
A segnalarci questa situazione e poi a metterci in comunicazione diretta è Rahmatullah Alizadah, un fotoreporter locale che ha trovato oggi riparo in Svizzera. Murtaza a 5 anni tirava calci a un pallone nel suo villaggio, situato in una discosta provincia rurale afghana; una foto lo ritrae con il sorriso timido e una busta della spesa in plastica bianca e azzurra, indossata sopra gli abiti a mo’ di pettorina, con il numero 10 e il nome di Messi scritti in pennarello. Nell’impossibilità di poter acquistare una vera e propria maglia del campione argentino, di cui è fan, si accontenta di questa replica ‘improvvisata’ ideata per lui dal fratello più grande. Nell’epoca dei social media che annullano le distanze, l’immagine catturata da un cellulare e postata su FB diventa virale e verrà in seguito rilanciata dalla stampa internazionale. È così che, nel 2016, il “piccolo Messi” si affaccia al mondo intero. Rahmat è stato il primo giornalista a raggiungere il bimbo reso famoso da internet, a documentarne la storia e anche a spendersi per attirare l’attenzione del calciatore sudamericano che, venuto a conoscenza della vicenda, con i buoni uffici dell’UNICEF, incontrerà Murtaza in occasione di una partita del Barcellona in Qatar.
L’improvvisa notorietà non apre però, come sperato, le porte a nuove opportunità. Al rientro in patria, di questa avventura nel Golfo non resteranno al bimbo che un pallone e la divisa ufficiale autografata dal calciatore. Murtaza e la sua famiglia saranno costretti d’ora in poi a nascondersi e a spostarsi frequentemente per sfuggire sia al rischio concreto di rapimento da parte di criminali convinti che il bimbo abbia ricevuto denaro, che dalle minacce dei fondamentalisti. Niente scuola, un’infanzia isolata e, con il ritorno del regime Talebano, un pericolo crescente e spostamenti che si fanno particolarmente frequenti (più di dodici solo nell’ultimo anno e mezzo); “qualche giorno fa, mio padre è stato riconosciuto in una panetteria, delle persone gli hanno parlato…anche i nostri vicini ci hanno fatto capire che sanno chi siamo. Qualcuno informerà i Talebani? È per questo che abbiamo cambiato di nuovo casa, per fare in modo che non ci capiti nulla”, leggiamo in uno dei tanti messaggi di Mahdia.
L’evacuazione
Mentre eserciti, diplomatici e organizzazioni internazionali si affrettano a lasciare il paese cercando di portare con sé i propri collaboratori, sui cellulari di veterani, giornalisti e cooperanti che per venti anni si sono occupati di Afghanistan e hanno stretto relazioni e amicizie con la popolazione locale, si affastellano le richieste di aiuto. Chi ha contatti utili li condivide in una catena infinita. Non solo personale militare, umanitario e professionisti dei media, impiegati amministrativi, giudici, avvocati, professori e attivisti, ma anche semplici cittadini in pericolo, tante donne e gli hazara, l’etnia invisa ai talebani e allo Stato islamico Khorasan (il famigerato franchise afghano di quello che fu l’ISIS in Siria e Iraq), alla quale appartiene la famiglia di Murtaza. L’aeroporto di Kabul è preso d’assalto da un fiume infinito di persone di ogni età che tenta di superare muri e sbarramenti per imbarcarsi sugli aerei diretti a Occidente, prima che l’Afghanistan venga abbandonato al suo destino; gli schermi televisivi mandano le immagini strazianti di chi si aggrappa a promesse e speranze infrante, e lo farà fino all’ultimo, trascorrendo giorni e giorni davanti ai cancelli. Le immagini che arrivano sulle chat dei telefoni sono ancora peggiori, fra spari e gente spaesata che scappa davanti ai bastoni delle guardie talebane, o che scivola nei canali di scolo.
Si portano fuori quanti più possibile, nelle ore caotiche anche senza controlli, con scelte cruciali e difficili anche per il personale delle rappresentanze consolari e ai cancelli dell’aeroporto. Sarà una gigantesca operazione di salvataggio di dimensioni inedite.
Il confronto con altre associazioni impegnate a salvare quante più vite possibile, poi arriva la conferma da parte della Difesa italiana. Luce verde: riusciamo a farli inserire nella lista di imbarco dell’ultimo volo. Migliaia di persone sono intanto ammassate al gate “Abbey”, l’ingresso dell’aeroporto in cui operano gli italiani e al quale la famiglia di Murtaza deve presentarsi entro poco tempo. Una missione che sembra impossibile, ma che tentiamo di realizzare in ogni modo, coordinandoci con il Colonnello T., che li attende all’ingresso. Ma le difficoltà aumentano con il passare del tempo, così come gli allarmi di potenziali attentati da parte del gruppo terrorista “Stato islamico” contro l’infrastruttura aeroportuale, ormai controllata congiuntamente dalle forze statunitensi e dai Talebani, i quali ne assumeranno la responsabilità dopo pochi giorni. Un allarme, in particolare, giunge la sera del 25 agosto: molto dettagliato, troppo preciso, diverso dai precedenti. Occorre decidere, in fretta. Lo facciamo: “fermatevi, non andate all’aeroporto, restate a casa domani”, consapevoli che tale decisione avrebbe impedito loro di salire su quell’aereo. In queste condizioni, per la famiglia di Murtaza, otto persone in tutto con bambini e un neonato al seguito, è impensabile rischiare il tutto per tutto per raggiungere l’uscita dove potrebbe essere aiutata dall’esercito italiano.
Quella scelta è stata invece la più giusta e fortunata, la migliore di quelle fatte nell’urgenza del momento. L’attacco suicida del 26 agosto, proprio lì al gate “Abbey” dell’aeroporto di Kabul, lascerà sul terreno più di 180 morti.
Rimangono aperte le altre opzioni che, parallelamente, avevamo tenute attive. I tanti “piani B”. I tentativi di trovare un passaggio sui pochi bus organizzati da non si sa bene chi, e che si spingono oltre i checkpoint dei talebani, sono un buco nell’acqua.
Si apre un’opzione prospettata dai veterani statunitensi. Con loro siamo in contatto dal primo momento e con loro si discute la possibilità di un’“operazione umanitaria” gestita da ex-militari. Esfiltrazione da Kabul, trasferimento al Nord, un aereo pronto a decollare. Murtaza e la sua famiglia, insieme ad altre centinaia di ex collaboratori che hanno lavorato per le forze armate statunitensi nella guerra più lunga, potrebbero essere recuperati in questo modo. Sembra un film, infinito, con la trama che scorre rapida e incalzante. Ogni decisione va presa subito, razionalmente e accettandone i rischi. Un’organizzazione caritatevole statunitense coprirebbe parte dei costi (molto elevati), quello che manca riusciamo a trovarlo con grandi difficoltà, ma l’eccezionalità del momento in questo caso aiuta. Una senatrice statunitense segue la questione con noi. Molto attivi anche alcuni parlamentari e militari italiani che a titolo personale si impegnano per trovare una soluzione. L’entusiasmo per tanta partecipazione è travolgente, reso amaro dai timori e dai messaggi disperati di Mahdia. Sembra tutto a posto, al netto del rischio concreto per chi dovrà portare a compimento l’operazione. Poi la doccia fredda: operazione annullata, non si fa.
Riuscire a lasciare il paese attraverso altre strade comporta costi e rischi non sostenibili. Fra carte e documenti, telefonate, e-mail e segnali lanciati in ogni direzione, per chi si trova in prima linea sul terreno o nelle retrovie, le ore passano frenetiche senza continuità fra giorno e notte. Pensare di portare in salvo tutti gli afghani in pericolo è un’impresa monumentale e impossibile, un’aspirazione nobile che si scontra con la realtà.
18 mesi di tentativi e di attesa
Con la partenza dell’ultimo volo il 30 agosto, l’Afghanistan torna di fatto un Emirato senza ambasciate. Chi non è riuscito a partire può richiedere un visto umanitario in uno stato terzo, ma per coloro che non hanno collaborato direttamente con ONG, media e contingenti militari esteri le difficoltà sono enormi, anche per ciò che riguarda il rinnovo o l’emissione di nuovi passaporti. I tempi sono lunghi, visti e documenti troppo costosi per i cittadini di un paese la cui economia, negli ultimi due decenni, è stata sostenuta soprattutto dalle donazioni e dalle iniezioni di denaro estero. Gran parte della popolazione vive sotto la soglia della povertà, la situazione critica si trasformerà velocemente in un dramma sociale di ampia portata.
Non ci scoraggiamo. Continuiamo a sostenerli, a cercare una via di fuga, tentiamo altre opzioni: pensiamo a un trasferimento via terra verso il confine. Prima l’Uzbekistan, poi il Tajikistan e il Pakistan. È una possibilità, rischiosa, me decidiamo di tastare il terreno. Scopriamo però che i confini sono stati doppiamente sigillati, da una parte i Talebani, dall’altra le autorità dei Paesi confinanti. Occorre un visto, un lascia-passare di un Paese terzo. Le tante telefonate alle ambasciate, ai ministeri e altre istituzioni in Italia, Svizzera e altrove, le interminabili attese, poi il nulla. I paradossi della burocrazia dipingono un quadro dalle tonalità drammatiche e quasi incredibili: “Possiamo rilasciare loro un visto” – ci dicono – “devono presentarsi direttamente in ambasciata, in Qatar, Pakistan ad esempio, o altro paese terzo”. Ma per arrivare all’ambasciata occorre attraversare legalmente il confine, con un visto che non possono avere prima, neanche in formato digitale, via posta elettronica.
Si chiudono le porte, una ad una.

I sorrisi di Mahdia e Murtaza il giorno della partenza per l’Italia
Si apre uno spiraglio: i corridoi umanitari
“Murtaza non ce la fa più a restare seduto in casa, mentre i suoi amici e tutti gli altri bambini vanno a scuola, imparano cose nuove. Piange tanto e si scusa per questo suo desiderio di essere come gli altri. Non riesco più a controllarmi, sono così dispiaciuta per lui, gli prometto che lo aiuterò, che sarà al sicuro e che le cose cambieranno”. È uno dei tanti messaggi di Mahdia, con cui ci sentiamo regolarmente. Ci spronano ad andare avanti, a insistere. Ci vorrà pazienza, ma non li lasceremo soli. Intanto, proseguono le triangolazioni, e settimane di silenzio.
Poi, il 4 novembre 2021, finalmente una bella notizia: la firma, al Viminale, del protocollo d’intesa per l’attivazione dei corridoi umanitari per i cittadini afghani. È la nostra chance. Prendiamo immediatamente contatto con Daniele, di Caritas Italia. Ci conosciamo da tempo e il suo aiuto si rivelerà fondamentale.
È il punto di svolta, iniziamo a lavorare per portarli in Italia. Ma i tempi e le difficoltà sembrano insormontabili: le difficoltà burocratiche si sommano a quelle oggettive. Occorrono i passaporti, che alcuni membri della famiglia non hanno, mentre altri sono intanto scaduti. Si corre contro il tempo, ma non contro la corruzione che, anzi, è l’unica via per ottenere i passaporti. È così, non ci sono alternative. Passano le settimane, poi i mesi. Nel frattempo, il padre di Murtaza viene catturato dai Talebani: imprigionato, torturato verrà rilasciato dopo diverse settimane, malato, previo pagamento di un riscatto. Ancora debole, lascia la famiglia in Afghanistan e si nasconde illegalmente in Iran. Nel frattempo, a ottobre 2022, arriva un’altra notizia positiva: la famiglia può presentarsi a Islamabad per il colloquio con i volontari della Caritas. Ottengono i visti, a un costo elevatissimo, e con questi superano il confine. Sono in Pakistan, tutti in salvo e pronti a partire per l’Italia, pensiamo. Ma non è così, manca il documento di una sorella, una giovanissima ragazza.
Che fare? La decisione è difficile, ma non può rimanere indietro. La famiglia si divide: Murtaza e il padre aspetteranno in Pakistan, mentre Mahdia, con il resto della famiglia tornerà in Afghanistan nel tentativo di ottenere in qualche modo il passaporto della sorella. Passeranno altri mesi: novembre, dicembre, gennaio, e finalmente il passaporto arriva.

La famiglia in aeroporto all’arrivo in Italia
È febbraio, Daniele ci informa che tutto è pronto per il trasferimento in Italia. La famiglia si lascia alle spalle un Paese che forse non rivedrà più, o almeno per molti anni. Possono prendere con sé poche cose: piccole valigie e borse, con dentro lo stretto necessario e qualche ricordo. Nulla di più, se non la volontà di ricominciare altrove e la speranza di un futuro migliore grazie a chi, impegnandosi per dar vita ai corridoi umanitari, ha realizzato un vero e proprio miracolo.
Oggi sono in Italia. La speranza è che si possano aprire opportunità concrete, per loro come anche per gli altri afghani che sono stati accolti e nei confronti dei quali il paese si è assunto l’onere del sostegno. Per Murtaza, soprattutto, che finalmente potrà studiare e giocare a calcio senza paura.
Questa è una goccia nel mare, che non chiude un capitolo ma che piuttosto, ne mantiene aperti tanti altri. Questa, è una storia di pazienza e perseveranza.
RINGRAZIAMENTI
… in questi mesi, in molti hanno preso a cuore la storia di Murtaza e si sono resi disponibili, in tempi diversi e in vari modi, con azioni concrete, suggerimenti o parole di sostegno: ONG, politici, militari, istituzioni e semplici cittadini in Italia, in Svizzera e negli Stati Uniti. Siamo grati in particolare a Daniele Albanese, Pierluigi Dovis, Mauro D’Ubaldi, Sua Eccellenza il Vescovo di Torino, Mons. Roberto Repole, Alberto Pagani, Lorenzo Guerini, Piero Fassino, Don Diego, Don Marco Di Matteo, Don Domenico Catti, NOVE Onlus, Gruppo Ticino di Amnesty International, la Senatrice Dianne Feinstein (D-CA), Rav. Arnold Rachlis, Luciano Portolano, Roberto Trubiani, Mauro Berruto, Isabella Rauti, Alessandro Sicchiero, Raffaella Virelli, Nicola Guerini, Luca Tenzi, Rahmatullah Alizadah, Farmanullah Turab, Ahmadullah Turab, Associazione Zenzero…. e a chi non siamo riusciti a raggiungere prima della pubblicazione di questo articolo oppure ha scelto di rimanere anonimo.