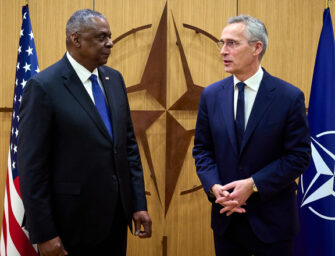#FocusEvento – Afghanistan
Roma, 18 gennaio 2019. Fondamentalismo e integrazione. Due temi importanti all’ordine del giorno in un incontro speciale a Palazzo Montecitorio. Sullo sfondo, la storia personale e la testimonianza di Farhad Bitani e l’analisi di Claudio Bertolotti.
Classe 1986, ex-capitano dell’esercito afghano nato e cresciuto in un paese costantemente in guerra, Farhad Bitani oggi risiede in Italia, dove si dedica tenacemente alla promozione del dialogo interculturale. Co-fondatore del Global Afghan Forum, un’organizzazione internazionale che si occupa dell’educazione dei giovani afghani, è anche autore del libro autobiografico intitolato ‘L’ultimo lenzuolo bianco. L’inferno e il cuore dell’Afghanistan’ da cui è stata tratta anche un’opera teatrale attualmente in tournée.
START InSight l’ha intervistato insieme al direttore Claudio Bertolotti, che ricordiamo è esperto di questioni politiche, militari e religiose dell’Afghanistan contemporaneo, già capo sezione contro-intelligence e sicurezza nell’ambito della missione ISAF e autore di una ricerca sul terreno confluita nel saggio ‘Shahid. Analisi del terrorismo suicida in Afghanistan’.
Quando l’uomo cambia, non può che lottare per la verità
Farhad Bitani
Lei viene spesso descritto come un ex-fondamentalista. Si tratta di una definizione scelta dai media, di un’approssimazione, oppure effettivamente sente che è così?
Effettivamente è così. Per come lo intendo io, il fondamentalismo è frutto dell’ignoranza, della violenza e della non accettazione del ‘diverso’ inteso come un ‘bene’. Sono cresciuto sin da piccolo in un paese dove tutte le caratteristiche sopraelencate erano presenti. Nel momento in cui ho deciso di aprirmi al ‘diverso’, ho avuto la possibilità di scoprire persone di razza, religione e culture differenti e dall’istante in cui ho accettato questa diversità, mi sono reso conto che prima ero un fondamentalista, e mi privavo della bellezza di un mondo alternativo al mio.
Che forma assume il fondamentalismo in un paese come l’Afghanistan che è già fortemente conservatore e con una profonda identità religiosa?
È un grande problema per un paese come l’Afghanistan, dove tutto è basato sulla religione, a partire dalla costituzione, che include tante leggi arcaiche. Non si può vivere in una società moderna con leggi e riforme datate. Come sappiamo, guerre e attentati in Afghanistan avvengono per mano di persone religiose a cui è stato fatto un ‘lavaggio del cervello’. È naturale per l’uomo cercare qualcosa di più grande, cercare Dio, ma quando in una società Dio e la fede sono usati come pretesto per portare avanti i propri interessi, ci ritroviamo in una situazione come quella afghana, dove tutti i più grandi criminali si ritengono religiosi. Ma in tanti passaggi del Corano sta scritto che il vero credente è colui che combatte con il suo ‘io’.
Nella locandina dell’incontro, si legge questa frase: “la verità è un gesto rivoluzionario e diffonderla lo è ancora di più”. Qual è questa verità di cui si fa portavoce?
Come detto, il jihad più significativo nell’Islam è quello con sé stessi. Quando una persona lotta e si impegna costantemente per migliorarsi, trova una grande libertà, che è un passo verso la verità. È accaduto anche a me. Nonostante io abbia vissuto immerso nella violenza, il mio cambiamento ha preso avvio da semplici gesti umani e dall’incontro con il diverso. E quando l’uomo cambia, l’obiettivo della sua vita diventa la lotta per la verità.
Cosa pensa del radicalismo che cresce, sotterraneo, nascosto, in Europa e che idea si è fatto dei moltissimi giovani che si sono arruolati nei vari gruppi jihadisti, giovani che vengono considerati ben integrati da chi gli vive accanto?
Quando l’uomo si sente abbandonato, quando in una società vengono innalzati dei muri che comprimono le libertà, l’‘altro’ viene visto come una minaccia. Gli jihadisti vengono da questo ‘buco nero’, sono il risultato di questa lacuna.
Porto un esempio personale, per spiegarmi meglio: avevo un amico in Germania che a un certo punto è ‘sparito’. Ho saputo in seguito da alcuni conoscenti che era partito per la Siria nel 2014. La vicenda mi ha molto turbato, anche perché non aveva mai dato segno di essere un fondamentalista. Eppure è andato a combattere una guerra che non aveva nulla a che vedere con le sue origini e il suo credo. Con il tempo sono riuscito a risalire ad una risposta. Ricordo le sue parole quando mi diceva: “vivo da 3 anni nello stesso palazzo, ma i vicini di casa non mi salutano, mi considerano un musulmano terrorista”. Ecco che dalla storia di questo ragazzo possiamo vedere come un uomo che si sente rifiutato o additato, può arrivare a scegliere strade sbagliate verso il terrorismo.
La pace con i talebani va fatta, ma soprattutto, sarà la soluzione per portare l’Afghanistan fuori dalla guerra?
L’Afghanistan soffre di 40 anni di guerra perché non abbiamo mai realmente cercato la pace. Ma con la violenza non possiamo risolvere nulla. L’Afghanistan strategicamente è un paese importantissimo; qualsiasi gruppo armato, che siano i talebani o altri, non appena si ritrova isolato e ‘fuori dai giochi’, ricorre alla violenza su incitamento dei paesi vicini, in quanto tutti i confinanti hanno interessi nei confronti di questo territorio dove si manifestano le rivalità, per esempio, fra Arabia Saudita e Iran, USA e Russia, USA e Iran, India e Pakistan. L’Afghanistan in pratica è come un campo di calcio per potenze internazionali. Se non convinciamo i gruppi armati a fare la pace, i paesi con tutt’altri obiettivi, continueranno a perseguirli promuovendo la violenza.
E alla fine, a rimetterci è e sarà sempre l’innocente popolazione afgana.
Il jihad fa parte del DNA afghano?
Il jihad visto nella sua connotazione positiva è nel DNA di qualsiasi musulmano, non solo afgano. Purtroppo in Afghanistan il concetto di jihad, dopo la guerra russa, ha perso il suo vero significato -cioè quello di sforzo per migliorarsi- e ha assunto i connotati negativi che tutti conosciamo.
Il jihad è stato usato per giustificare azioni politiche che altrimenti non sarebbero state accettate dalle opinioni pubbliche dei fronti contrapposti
Claudio Bertolotti
Un paio di recenti sviluppi positivi e un paio di sviluppi negativi per dare un’idea delle difficoltà e delle opportunità con le quali si sta misurando l’Afghanistan?
Nell’ampio quadro in cui si colloca la guerra in Afghanistan ci sono molte dinamiche altamente destabilizzanti e precarie. Tra gli aspetti positivi certamente il passo avanti nel dialogo negoziale con i talebani che potrebbe aprire a questi l’accesso al potere, a fronte di una riduzione della presenza militare straniera nel Paese. Siamo ancora lontani dal dire quando ciò potrà avvenire, ma si è via via presa consapevolezza dell’impossibilità di vincere la guerra contro i talebani: il processo negoziale è come un’uscita di sicurezza quando tutto intorno sta crollando. Un secondo aspetto positivo è certamente il ruolo sempre più concreto degli attori regionali impegnati nella stabilizzazione del Paese: in primis la Cina, che in Afghanistan ha investito molti capitali nel settore minerario ed estrattivo e che desidera un paese stabile ai propri confini e libero dall’ideologia islamista che preoccupa Beijing per ragioni di politica interna; una preoccupazione che nasce dalle istanze indipendentiste della minoranza musulmana uigura alle quali si sovrappongono le contaminazioni del crescente jihadismo transnazionale. In secondo luogo, la Russia, sempre più propensa ad assumere un ruolo determinante per la stabilità del Paese.
Tra gli aspetti negativi certamente il livello di povertà in cui il Paese è precipitato, a causa della guerra e della diffusa insicurezza ed incertezza: 24 % di disoccupazione, 15 % della popolazione incapace di provvedere ai propri bisogni essenziali, e ben il 54% che vive al di sotto della soglia di povertà. Una povertà che si somma all’altro aspetto negativo, e in parte ne è la conseguenza: la debolezza dello Stato afghano, che dipende in tutto e per tutto dal sostegno, in primis economico, della Comunità internazionale, e che è incapace di garantire la sicurezza dei suoi cittadini e di contrastare un’avanzata ormai inarrestabile dei gruppi di opposizione armata, dai talebani al nuovo e pericoloso attore: lo Stato islamico-Khorasan, il franchise afghano di ciò che fu il Califfato di Abu Bakr al-Baghdadi in Siria e Iraq.
Nel 2019 cade un anniversario importante, si ricordano i 40 anni dall’invasione sovietica. Che rilevanza ha oggi questa ricorrenza?
Il mondo è cambiato radicalmente dal 1979, ma l’Afghanistan continua a essere un elemento dinamico degli equilibri geopolitici e delle relazioni internazionali. Quello sovietico fu un grande errore, dagli effetti devastanti per l’Unione Sovietica, i cui sforzi in Afghanistan contribuirono a determinarne il collasso. Gli Stati Uniti, seppur con numeri inferiori, hanno dovuto far fronte a un impegno che ha portato il costo della guerra a raggiungere nel suo complesso la mostruosa cifra di mille miliardi di dollari. La guerra afghana, che 40 anni fa entrò nella competizione tra i due grandi attori dell’epoca – Stati Uniti e Unione Sovietica – continua oggi a essere terra di scontro tra interessi politici, ideologici ed energetici.
Come è cambiato il panorama dello jihadismo e del fondamentalismo in Afghanistan rispetto ai primi dieci anni del 2000, quando ha studiato da vicino, sul posto, i contesti degli attentatori suicidi?
Credo che ogni generazione di afghani abbia ereditato dalla precedente una crescente e sempre più profonda accettazione alla guerra. Se nasci e cresci in una realtà in cui violenza, paura e morte fanno parte della quotidianità, divieni vittima di un circolo vizioso che allontana sempre più da uno scenario diverso. La guerra è devastante e persistente: sono trascorsi 18 anni da quando la Coalizione internazionale guidata dagli Stati uniti ha invaso l’Afghanistan, più di 15 da quando ci sono andato per la prima volta. Molte cose sono cambiate, incluso quel fronte che per anni ha contrapposto gruppi più o meno eterogenei di ribelli, insorti e terroristi alle forze internazionali e al sempre più debole Stato afghano, portando alcuni dei vecchi signori della guerra, quelli che a lungo siamo stati abituati a chiamare mujaheddin – con accezione positiva – a mettere le mani su un mercato della droga sempre più fiorente e redditizio. A questi si uniscono i gruppi insurrezionali afghani, impegnati in una guerra di resistenza che sovrappone i propri ritmi agli interessi della criminalità organizzata transnazionale; degli Stati che, per ragioni diverse, guardano a un Paese su cui vorrebbero esercitare controllo e, ancora, ai crescenti e sempre più preoccupanti soggetti e gruppi che giungono in Afghanistan fuggendo da altri teatri di guerra, come la Siria o l’Iraq. Oggi l’Afghanistan, ancora più di quanto non lo sia stato in passato, è un campo di battaglia su cui si riversano centinaia, forse migliaia, di jihadisti, terroristi fortemente ideologizzati, che stanno trasformando quella che è stata una guerra di tipo nazionale, regionale, in un conflitto globale. 15 anni fa, quando iniziai i miei studi sul fenomeno degli attacchi suicidi, gli attentatori erano tutti afghani; oggi non è più così, molti di questi sono stranieri, e tra di loro anche soggetti con passaporto europeo. È la modernità della guerra, che si adegua alle dinamiche globali.
Il jihad fa parte del DNA afghano?
Il jihad è un elemento forte, sul piano ideologico e motivazionale, che alimenta una conflittualità che ha ragioni di tipo prevalentemente politico, economico e strategico. Sul piano politico gli Stati Uniti hanno sempre usato l’Afghanistan per gestire i propri equilibri di politica domestica, con continue revisioni delle strategie in concomitanza con gli appuntamenti elettorali. Sul piano economico i talebani hanno saputo trarre grande vantaggio dall’economia di guerra, in gran parte basata sulla droga, che è causa e conseguenza della guerra stessa. Sul piano strategico per gli Stati Uniti la presenza in Afghanistan è una necessaria garanzia in un’ottica di contenimento cinese, ma anche di vantaggio su Iran, repubbliche centro-asiatiche, Pakistan e India.
Il jihad è stato usato su tutti i fronti per giustificare azioni politiche che altrimenti non sarebbero state accettate dalle opinioni pubbliche dei fronti contrapposti. Da una parte la retorica della ‘necessità’, del ‘dovere’ di aderire al jihad per la difesa della propria terra e dei propri valori. Dall’altra parte, non meno retorico, l’approccio occidentale della ‘guerra al terrore’, quell’impegno a contrastare il terrorismo jihadista che ha caratterizzato gli ultimi due decenni e che ancora oggi è di estrema attualità e che riesce a smuovere l’animo delle masse di cittadini pronti a giustificare le scelte di politica interna ed estera dei propri governi in cambio di una promessa di maggiore sicurezza.